Cesare Viel
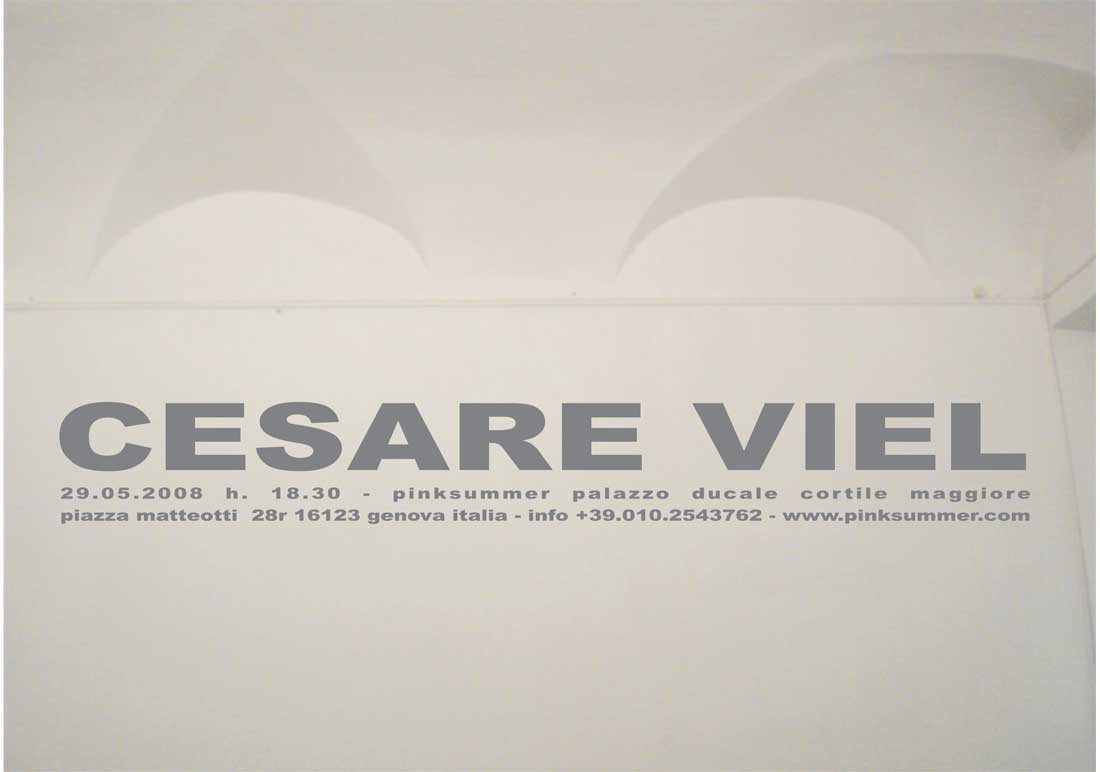
Pinksummer: Artaud ha scritto a proposito del suo teatro: “Popolare lo spazio per coprire il vuoto, è ritrovare il cammino del vuoto”. Artioli e Bartoli in uno straordinario saggio su Artaud hanno ricondotto la metafisica linguistica artaudiana a quella situazione di sospensione che ricerca il punto vibratile in cui ciò che è forma comincia a svanire, materia dissociata che produce energia, soffio, distruggendo il feticismo del testo e il nesso tra significato e significante. Tale parola non è raptus incontrollato, ma conoscenza delle leggi della vita che oscillano tra pieno e vuoto con un ritmo duale centrifugo e centripeto. Questa tua seconda personale da pinksummer è materializzata dal e sul e intorno al linguaggio. La tua strategia linguistica sembra galleggiare tra presenza e assenza; la tua parola, materia cristallizzata, appare sul punto di sciogliersi e vivere autonomamente prendendo la forma del trasalimento dell’anima. Il primo spettatore di questa mostra sembri essere tu: nella scena teatrale artaudiana concepita in modo circolare il vuoto sta al
centro, nel punto in cui si trova lo spettatore, il pieno sta ai margini, in procinto di essere inghiottito dal nulla.
Cesare Viel: Ho sempre avuto una forte attrazione per il vuoto e i precipizi. Da bambino mi affascinava esporre una bambola al di là della ringhiera del mio balcone, al sesto piano. Restavo a guardare il corpo del giocattolo sospeso nel vuoto, tenuto solo dalla mia mano. Provo sempre un brivido creativo quando vedo i tuffatori che si lanciano dal trampolino più alto e, nel giro di qualche secondo, si trasformano in proiettili perpendicolari che bucano la superficie dell’acqua. E’ come trovarsi sul bordo di una diga e osservare da una parte il lago d’acqua, dall’altra il muro verticale di contenimento, e sentire la forza immensa dell’energia lì presente.
Da adulto ho capito che queste esperienze sono profondamente collegate al duplice stupore per l’esistenza – la sua meravigliosa e sconcertante gratuità – e per il linguaggio che ci contiene, ci descrive, cerca di render conto di questo vuoto, di perimetrare questa sensazione di precipizio. Il linguaggio è forse come la mano del bambino che tiene in pugno il giocattolo sospeso nel vuoto, mentre osserva se stesso, il giocattolo, l’orizzonte dello spazio in cui è immerso, tutte le cose intorno, il contesto complessivo – e imprendibile – di questa situazione. Le parole possono far vedere tutto questo, anche quando non è più presente.
Il linguaggio crea le immagini e nello stesso tempo può dissolverle. Questa capacità del linguaggio di costruire e dissolvere, far vedere e andare al di là del vedere, è per me un nucleo di energia potentissima.
Dentro il linguaggio c’è una tensione ad uscire da se stesso, e c’è per questo anche una mancanza, un vuoto, che attrae.
I primi spettatori di questo spettacolo dell’esistenza e del linguaggio non possiamo che essere noi stessi mentre facciamo questa esperienza, e poi cerchiamo di farla vedere anche agli altri, stupiti che non ce l’abbiano indicata subito come la cosa più importante. Perché non ce l’ hanno voluta raccontare questa esperienza del vuoto in sé quando eravamo bambini? Per non spaventarci, per proteggerci? Perché è inspiegabile, paradossale, insopportabile da gestire? Non si finisce mai di fare i conti con il vuoto, con la mancanza di fondamenti. Artaud lo ha capito e attraversato fino in fondo.
P: Platone nel “Fedro” muove da un discorso sull’amore e sulla bellezza per rivendicare il valore ontologico della parola affermando che il discorso del retore è basato sull’opinione e sul criterio della verosimiglianza e pertanto può dire tutto e il contrario di tutto, mentre il discorso del filosofo è basato sulla conoscenza
dell’oggetto intorno al quale si parla e sulla conoscenza dell’animo degli uomini che il discorso deve persuadere. In questo senso Socrate, nel dialogo platonico, distingue l’oralità dalla scrittura: “Il vero libro del filosofo non è quello che egli scrive sulla carta, bensì quello che egli scrive nell’anima degli uomini”. Paragona la scrittura a un gioco, quello del “giardino di Adone”, in cui per festeggiare Adone si seminavano in vaso dei semi che fiorivano e sfiorivano in pochi giorni senza produrre frutti, mentre l’oralità
al lavoro dell’agricoltore che porta alla raccolta del frutto, frutto che genera altri semi, e dunque l’oralità per Platone è linguaggio immortale. Il tuo linguaggio, anche rispetto al lavoro performativo, sembra cercare l’identità tra oralità e scrittura, in entrambi i casi tu cerchi una distanza dalla tua parola, l’hai già abbandonata a se stessa: anche in presenza del gesto, la parola è già stata pronunciata e tu rimani muto. La parola aleggia nell’aria come eco, ormai lontana da te.
C.V: Fin dai miei primi lavori mi sono accorto che ero trascinato dalla parola. La parola mi diceva e mi oltrepassava. Dentro la dimensione indicale della scrittura a mano – del gesto e dell’azione dello scrivere – scaturisce un moto perpetuo di potenzialità del linguaggio. Dalla parola scritta alla parola detta – la grana della voce – il gioco di rimandi è infinito. Quando faccio un lavoro di parola non so mai che cosa nasca prima, se l’oralità o la traccia scritta del pensiero. Vengono insieme, sopraggiungono, si presentano insieme, e nello stesso tempo sono già divise dentro. Sono già spezzate, attraversate nella loro contingenza. Non cerco di ricomporle – l’oralità e la scrittura – pretendendo da loro una prestazione unitaria e monolitica: un’astratta e unica voce. Mi fanno presente il loro diritto di esistere. Allora cerco di rispettare le loro differenze, il loro molteplice – e amoroso – rapporto.
Cerco di far emergere la loro reciproca sconnessione.
La parola si manifesta in molte forme: scritta, vista, pronunciata, cantata, pensata, rimossa, ascoltata, letta, agìta. E’ subito presa in un’ interminabile relazione plurale, singolare, privata e pubblica. L’eco è ciò che resta della parola che non è più tua ma ti chiede ugualmente di essere ripresa, ancora e ancora, per riproporla in un circuito che non vuole finire mai.
P: Rispetto alla sospensione creata dal linguaggio in questa tua mostra, ci viene da guardare verso l’inespresso, o meglio verso l’inesprimibile inteso come impossibilità a esprimere descritta con
meravigliosa eloquenza lirica dal Dante del Paradiso, ma con altrettanta pregnanza e concretezza da Wittgenstein nel Tractatus, il quale cercando una struttura linguistica logicamente perfetta basata
su un rigido parallelismo con la realtà, traccia un limite davanti al nostro pensiero: “su quello di cui non si può parlare occorre tacere”, la saggezza sta dunque nel silenzio e l’etica nella parte non scritta del Tractatus. Ammesso dunque che esista il soprasensibile, esso non può essere espresso dal nostro linguaggio
essendo il linguaggio il confine invalicabile del nostro mondo costituito da fatti. Al di là di quel limite non può esistere espressione, e ammesso che esista essa non ci appartiene. In quel limite qualcuno ha intravisto il misticismo di Wittgenstein: il mistero della fede. In questa tua mostra la parola sembra tentata di incamminarsi oltre a quel limite, lo fa intuire a chi ascolta, a chi legge, e proprio in chi ascolta, in chi legge essa trova la concretezza del limite e nel contempo la sua possibilità.
C. V: Qui, per me, si affaccia la questione centrale del corpo – e intendo anche quello dell’arte -. A volte il corpo vuole dormire fino a tardi – restare a lungo nel buio -, a volte si alza all’alba e cerca il contatto con la prima luce del giorno. La motivazione di questi comportamenti è del tutto esprimibile? Resta in fondo, dopo tutto ciò che riusciamo a spiegare, un residuo che si fa sentire, che continua a resistere e che non si può dire. E’ questa resistenza a dirsi che mi interessa. Ciò che non si può esprimere lo si indica, lo si mostra, ha detto Wittgenstein. Il corpo agisce l’inesprimibile, e il linguaggio è un corpo.
Ciò che non si può dire è lì davanti a noi, e noi lo vediamo.
Come al mattino la prima luce del giorno. L’arte va là, e insiste, dove si annida l’inespresso. Tutta la mostra lavora intorno – e grazie – a questa dimensione.
P: Come si articolerà il tuo progetto da pinksummer?
C.V: Tre nuove opere: “Avvicinandoti a distanza” che affronta la dimensione verticale e frontale;
“Ti sento passare” quella allargata; “Mi trovavo a casa” quella circolare, intima e avvolgente. Ruotano attorno a un evento personale, intenso. Un passaggio del limite, un incontro col vuoto, con un’assenza, con un silenzio che si trasferisce e vive nel linguaggio: camminare sui suoi margini per indicarne la forza fantasmatica e rigeneratrice. Nucleo carico di energia che si relaziona con lo spazio, e si consegna apertamente alla lettura, all’ascolto, pubblico e plurale – sia letterale – sia metaforico – degli altri.


